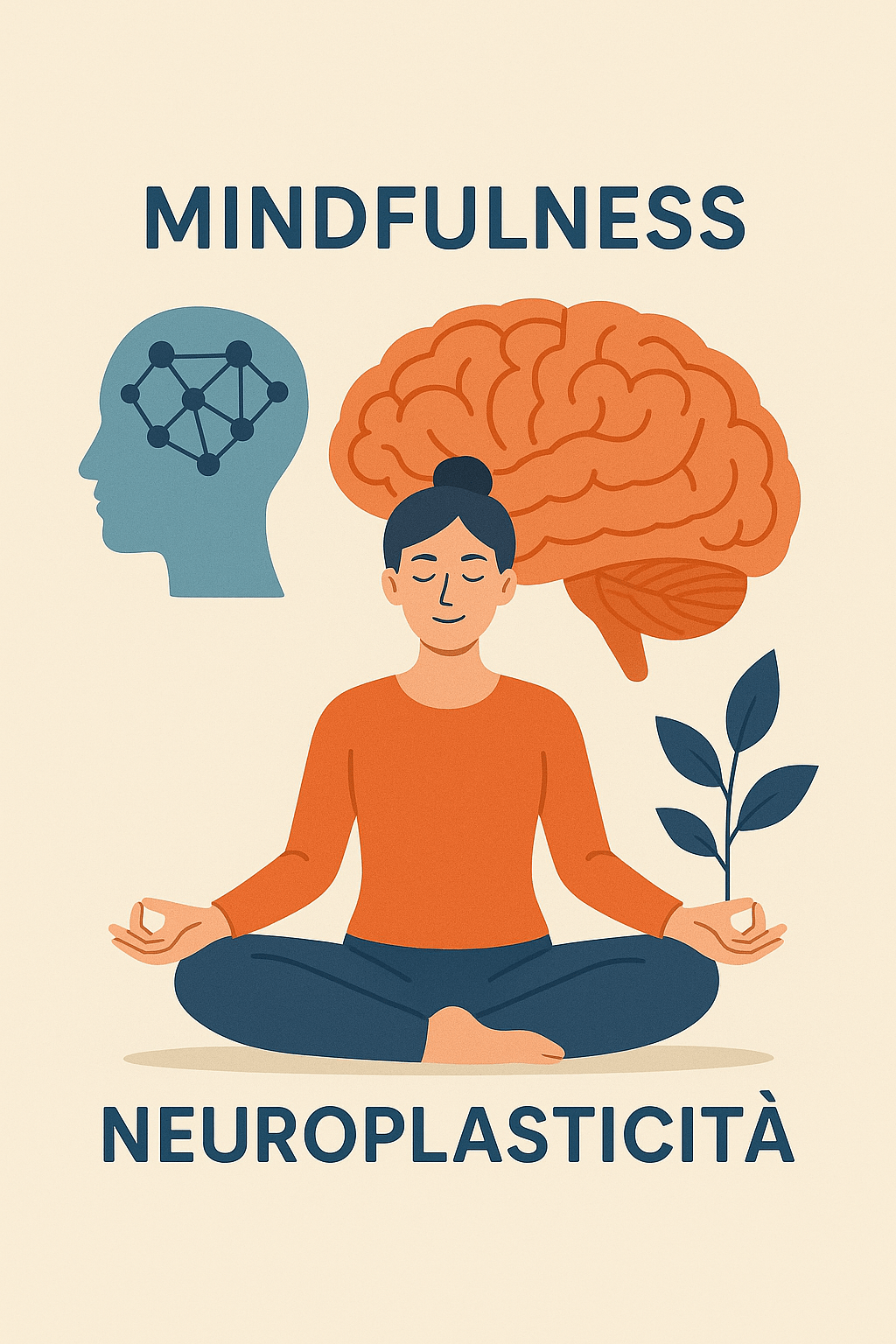Minosa Martini è uno dei volti più noti del Tg5. Grazie al suo coraggio e alla sua passione, da anni documenta ciò che accade nelle zone più pericolose del mondo, dove imperversano conflitti e guerre fratricide. Profonda conoscitrice del Mondo Arabo, ci spiega con la solita chiarezza che la contraddistingue, cosa sta avvenendo nelle zone calde del mondo e quali scenari si prospettano per il futuro.
La Primavera Araba sembrava aver portato una ventata di novità in Nord Africa e in Medioriente ma a distanza di un anno l’entusiasmo si è spento e il malcontento è riesploso un po’ ovunque. Cos’è successo?
Innanzitutto è doveroso fare una premessa: abbiamo assistito e stiamo assistendo a una profonda rivoluzione politica, sociale e culturale in tutti i Paesi del Mondo Arabo e questa rivoluzioni ha i suoi tempi, è un processo lungo di cui non si vedrà la fine a breve. Inoltre, ogni paese ha le sue peculiarità che lo rendono diverso dall’altro. Se parliamo della Libia dobbiamo considerare che là non c’è mai stata una democrazia, lo stesso Gheddafi diceva di non essere il presidente. Per loro la sfida è inventare un processo politico e democratico. Diverso è il caso della Tunisia, molto simile a noi culturalmente, un Paese che, a differenza dell’Algeria, non ha grandi risorse e vive prevalentemente di turismo. La contaminazione culturale è lunga secoli e non è un caso che la Primavera Araba sia nata là. Ora, però, si presenta un problema politico, una divisione tra le frange più laiche della popolazione e quelle più legate all’Islam, che devono superare gli scontri e trovare un accordo su come far crescere il Paese. C’è chi spinge per accelerare la modernità, chi vorrebbe imporre la sharia, che significherebbe tornare indietro socialmente e culturalmente.
Qualcosa di simile sta avvenendo in Egitto dove Morsi rivendica poteri dittatoriali. Pensa che la Fratellanza musulmana stia minacciando il processo democratico?
L’Egitto è il Paese maghrebino più popoloso, ha profondi legami con gli Stati Uniti che finanziano l’esercito in cambio della mediazione con Israele. Anche lì è in atto uno scontro tra le forze progressiste che lottano per uno Stato laico sul modello delle nazioni occidentali, e i tradizionalisti che invece vorrebbero la sharia come base per il sistema legislativo. In questo contesto, i Fratelli Musulmani rappresentano senz’altro un pericolo per il processo democratico, ma non bisogna dimenticare che sono stati eletti dalla maggioranza della popolazione. Ora vogliono semplicemente imporre il loro modello di Paese. Ciò che è sconcertante invece è il decreto emanato da Morsi in cui si proclamava al di sopra di ogni legge. Questo è estremamente antidemocratico e pone l’Egitto in una situazione delicata anche dal punto di vista della politica estera. I Paesi occidentali, infatti, si sentono minacciati da un possibile passo indietro dell’Egitto sul piano politico, culturale e sociale.
In molti sono scesi in piazza contro il presidente ma a quali correnti appartengono i manifestanti?
Ero in Egitto quando sono scoppiate le rivolte un anno fa e quello che sta accadendo quest’anno è qualcosa di profondamente diverso. Sono scese in piazza molte più persone, quella che potremmo definire la borghesia laica e illuminata del Paese, donne che non portano il velo. Le stesse donne che un anno fa, dopo la caduta di Mubarak, si recarono in piazza Tahrir sui loro Suv, armate di scope nuove, per ripulire i resti della rivoluzione. Oggi quelle donne stanno manifestando insieme a un’ampia frangia delle popolazione contro il colpo di mano di Morsi e il pericolo della sharia che riporterebbe l’Egitto indietro di secoli.

Parliamo della Siria. Di oggi la notizia che gli Stati Uniti sono pronti a riconoscere quale rappresentante del popolo della Siria la Coalizione nazionale creata a novembre. Questo come cambia gli scenari?
Gli Usa hanno sempre sostenuto i ribelli schierandosi contro il regime ma non avevano mai preso posizione apertamente e ufficialmente come ha fatto oggi Barack Obama. Il conflitto siriano si trascina in maniera tragica da un anno e mezzo, è una guerra civile feroce che massacra indistintamente uomini, donne e bambini. A ciò sono legati altri problemi come il traffico delle armi, l’equilibrio delle alleanze interne e internazionali e la presenza di Al-Qaeda che spera di estendere il suo dominio alla Siria. Inoltre, la guerra civile si allarga anche alla sfera religiosa, tra la maggioranza sunnita che è dominata dalla minoranza sciita alawita. È una situazione da cui è difficile uscire, ma ancora più difficile è trovare il modo di farlo. Nessuno può intervenire militarmente, né gli Usa né l’Europa, allora si era ipotizzato di armare i ribelli, ma il problema non sono le armi, che circolano in abbondanza. Credo che Bashar al Assad farà una brutta fine, come tutti i dittatori, ma non è possibile prevedere quale corso prenderà il Paese, anche perché dietro ci sono gli interessi dell’Iran, a cui la vicenda Siria è servita per distogliere l’attenzione dal pericolo nucleare. Si è ipotizzato di istituire una no fly zone, ma a chi affidare il compito di vigilare? Alla Turchia, che sta cercando di ritagliarsi un ruolo di primo piano sulla scena internazionale? Ma cosa chiedono in cambio i turchi? La questione è davvero troppo delicata, bisognerebbe sedersi a tavolino e analizzare tutti questi aspetti.
Parliamo di Palestina: pensa che il fatto che sia sta riconosciuta come Stato osservatore non membro dell’Onu sia un passo verso il riconoscimento totale e la risoluzione del conflitto con Israele?
Quando ero in Israele ho parlato sia con israeliani che palestinesi ed entrambi hanno desiderio di vendetta per ciò che hanno subito 10, 20, 50 anni fa. Ma se si continua a rivangare il passato non se ne esce più. Bisogna buttarsi dietro le spalle i vecchi torti e avere il coraggio di fare dei passi in avanti, essendo disposti a stringersi la mano, come ha fatto Rabin con Arafat. Il più delle volte i nemici sono gli estremisti interni. Il riconoscimento della Palestina da parte dell’Onu è un primo passo ma non aspettiamoci che abbia effetti immediati. La strada della pace è ancora lunga e i passi da compiere sono ancora molti.
Lei è stata inviato del Tg5 in Afghanistan e Iraq e dalla sua esperienza è nato il libro Kashmir Palace. Cosa l’ha spinta a scrivere questa storia e soprattutto perché ha scelto la formula del romanzo anziché quella del reportage giornalistico?
Di reportage ne erano usciti già tantissimi, era un genere inflazionato già mentre mi trovano in Afghanistan, da dove sono rientrata nel gennaio 2002, quando ancora non era stato formato il governo Karzai. Avevo pensato di scrivere un istant book ma le case editrici mi hanno risposto che gli italiani non erano interessati ad altre storie di guerra, erano stufi delle cattive notizie. Mi sentivo scoraggiata e disgustata, e così il tutto è rimasto in sospeso. Tuttavia avevo voglia di raccontare tutto ciò che, per mancanza di spazio, non ero ancora riuscita a documentare così ho pensato alla formula del romanzo, che permettesse di mantenere in ombra il mio personaggio e sentirmi libera di raccontare delle verità senza doverle giustificare, come avrei dovuto fare se avessi scritto un reportage giornalistico. Non ho descritto solo la guerra, ma anche l’enorme circo mediatico che questa scatena, gli amori e gli odi tra giornalisti, ciò che in genere rimane celato.
Come vive la popolazione in quei Paesi dilaniati da anni di guerre fratricide e quanto è importante raccontare la loro quotidianità?
Chi vive in Paesi pacifici non immagina neppure cosa sia la guerra, inoltre quelle sono popolazioni poverissime, abituate a essere vessate dalla criminalità e dalla corruzione. Anche per ottenere un semplice documento, sono costretti a pagare la mazzetta all’impiegato. Se hai un’automobile – e questo mi è accaduto in prima persona – ogni volta che vieni fermato dalla polizia, insieme ai documenti devi consegnare anche una somma di denaro. Ma per loro tutto questo è normale. Quanto al raccontare, posso dire con certezza che, per noi che assistiamo a vicende truci, è l’unico modo per liberarci dal senso di impotenza che ci attanaglia ogni volta che vediamo innocenti assassinati o bambini che muoiono di fame. Non possiamo fare niente per aiutarli concretamente, ma raccontare le loro storie riempie il vuoto che ci portiamo dentro e ci dà la sensazione di non essere inutili.
Piera Vincenti